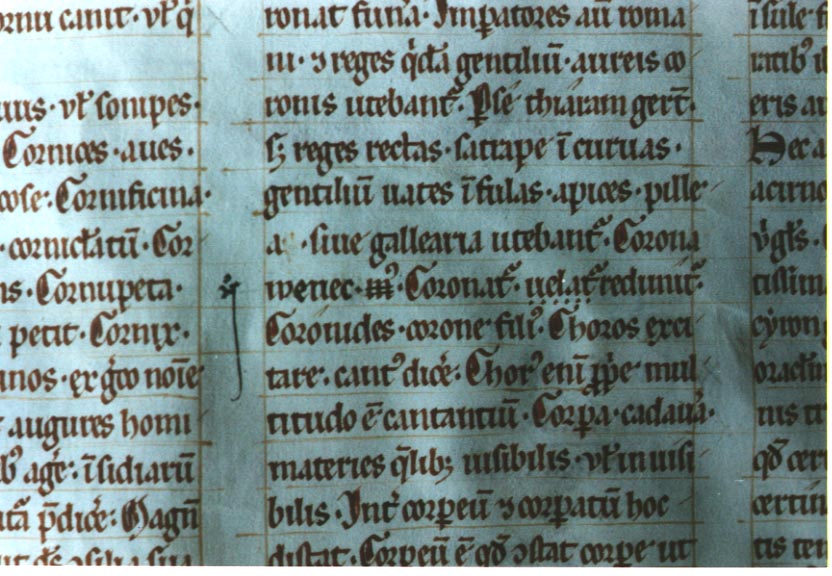I racconti che ci vengono tramandati dai nostri antenati in forma di miti e leggende appartengono ad un passato ancestrale che molto ci rivela della concezione della vita e del mondo dei nostri progenitori.
Molti studiosi sostengono, ad esempio, che le genti pre-indoeuropee che abitavano il nostro continente (per le quali gli studiosi hanno coniato il termine di Old Europe ma che noi conosciamo anche con il nome di Mediterranei, pur se abitavano anche zone dell’entroterra balcanico) praticassero riti religiosi che presupponevano l’idea della reincarnazione, vale a dire del continuo ciclo della morte e della rinascita.
Una tale concezione non poteva non essere tipica di popolazioni dedite all’agricoltura, che avevano fatto proprie le nozioni di nascita, morte e del fluire continuo delle stagioni. Non è un caso che molti dei motivi decorativi attribuiti ai pre-Indoeuropei contengono il simbolo della spirale, che di per sé richiama l’idea del ciclo del divenire.
Inoltre, poiché la sopravvivenza di questi dipendeva prevalentemente dal raccolto, essi tendevano a mitizzare la terra e i fenomeni naturali. Molte delle divinità antiche dell’Europa «risiedono» infatti nella terra, come la Gran Madre raffigurata in molte sculture preistoriche o negli antichi templi delle isole del Mediterraneo (Malta, Creta). Nel mondo ellenico essa aveva il nome di Potnia e sarebbe poi diventata, in epoca storica, la divinità che Esiodo chiama Gaia (o Gea).
La misurazione del tempo, invece, era alla base delle costruzioni megalitiche sparse nel Vecchio Continente e, in particolare, nelle isole britanniche come Stonehenge in Inghilterra e Newgrange in Irlanda; la disposizione dei menhir e dei dolmen consentiva infatti di poter scandire con relativa precisione l’avvicendarsi delle stagioni, consentendo con tutta probabilità agli sciamani di prevedere il favore degli elementi e l’andamento del raccolto.
È noto infatti che, sotto il tumulo di Newgrange (che risale al 3200 a.C.), è stato scavato un cunicolo che accede ad una camera mortuaria: il sole riesce a filtrare in questa stanza solo all’alba del solstizio d’inverno, che costituiva per molte genti l’inizio del nuovo anno; un’opera di questo genere presuppone non solo una raffinata conoscenza del tempo e delle stagioni ma anche uno studio analitico della posizione del sole all’orizzonte, al suo sorgere. È inoltre evidente che opere come quelle dei megaliti preistorici impegnassero più di una generazione (la vita media, all’epoca, a stento superava i trenta anni): esse richiedevano una notevole organizzazione e una raffinata concezione religiosa, anche in considerazione del fatto che molte delle pietre utilizzate per realizzare queste opere provenivano da località molto distanti rispetto al sito in cui è stato costruito il monumento.

Culto della madre terra, credenza nella reincarnazione e profonda conoscenza dei cicli temporali e delle stagioni: questo ci dicono le opere preistoriche dei nostri antenati.
Una tale concezione si riverbera anche sul concetto di sepoltura: i popoli della Old Europe praticavano l’inumazione, vale a dire il ritorno alla terra (unico elemento stabile in una comunità agricola); i rituali erano molto semplici e sobri, essendo la morte solo un mero momento di passaggio nel ciclo della continua rinascita.
Diverso discorso bisogna fare per le popolazioni appartenenti al gruppo degli Indoeuropei che, in un periodo compreso tra il V e il II millennio a.C., colonizzarono (o conquistarono) l’Europa e l’Asia Minore partendo probabilmente da un nucleo sito nelle steppe della odierna Russia (c.d. cultura dei Kurgan).
Le stirpi indoeuropee erano essenzialmente nomadi, ragion per cui le loro credenze religiose non potevano non essere influenzate da questo fattore: le loro divinità risiedevano in cielo, in quanto unico elemento stabile e ricorrente nelle loro peregrinazioni; nacquero così teofanie basate sulla adorazione del sole, del cielo e delle manifestazioni più terribili che da esso provengono: il tuono ed il fulmine.
I rituali di sepoltura riflettevano anch’essi il modo di vivere di queste genti: gli antichi Indoeuropei, infatti, praticavano in prevalenza l’incinerazione; il cadavere veniva bruciato e le ceneri conservate in un’urna, che veniva poi gelosamente custodita dai familiari, che la trasportavano agevolmente durante le loro peregrinazioni senza separarsene mai e dando vita ad un vero e proprio culto per gli antenati.
La religione di molte delle popolazioni storiche che ci hanno preceduto deriva proprio da una fusione (non sappiamo se pacifica o derivante da vere e proprie invasioni) tra elementi mediterranei e indoeuropei.
Emblematica, in questo senso, appare la religione degli Elleni, la cui cultura deriva dalla sintesi tra la popolazione autoctona dei Pelasgi e quella proveniente dal nord, costituita da Achei, Ioni ed Eoli.
Le divinità e i culti appartenenti a popolazioni provenienti da ceppi diversi hanno dato vita ad un corpus mitico che non ha eguali nella storia del mondo antico, ma che agli occhi del lettore moderno presenta palesi contraddizioni.
È evidente, infatti, che l’incontro tra due concezioni religiose diverse ha prodotto un insieme di divinità le cui attribuzioni sono, per così dire, in competizione tra di loro (quando non si verificano veri e propri «doppioni», come nel caso di Helios e di Apollo, entrambi legati al culto del sole).
Tali apparenti antinomie possono agevolmente spiegarsi ove si riconosca che, essendosi fusi due popoli che avevano già elaborato un pantheon completo di credenze, si sono poi dovuti misurare con il patrimonio mitico di altre genti stanziate nella penisola ellenica.
I sacerdoti, i profeti e i cantori del periodo intermedio hanno evidentemente faticato non poco per cercare di armonizzare due concezioni della vita opposte, l’una ispirata al culto della terra e l’altra che tendeva a divinizzare il cielo.
La genialità dello spirito greco, che nei secoli ha sempre cercato di inglobare il «diverso» per arricchire il proprio sistema di credenze, sta nell’aver ideato una vera e propria teogonia in cui le divinità si sono trovate in competizione tra di loro, facendo nascere un vero e proprio conflitto tra numi della prima e della seconda generazione.
Non è inutile evidenziare che, in una prima fase, gli Elleni identificavano il sacro con le forze naturali (pare che gli dèi più importanti fossero Poseidone e Demetra), per cui la divinità veniva raffigurata simbolicamente con un aspetto animale, ovvero metà uomo e metà animale (in alcuni casi, addirittura, la divinità è rappresentata come una orrida commistione tra animali diversi): tale iconografia religiosa è nota anche come «naturalismo».
Successivamente, tale concezione venne superata identificando il sacro con elementi tipicamente umani e anche gli dei vennero raffigurati in forma umana, anche se idealizzati («antropomorfismo»): i figli di Crono e i loro discendenti erano raffigurati come degli umani «perfetti», in quanto erano immortali, ma con tutte le passioni e i vizi degli uomini: dall’amore alla collera, dall’amicizia alla gelosia.
L’originalità del pensiero ellenico sta nell’aver concepito uno scontro tra gli dèi che è inizialmente culminato nel trionfo delle nuove divinità (molte delle quali, ma non tutte, appartengono all’universo indoeuropeo) ma che poi si risolve nell’armonia (kósmos) tra la vecchia e la nuova stirpe dei numi.
Dopo aver sconfitto al termine di un’aspra battaglia i Titani e il mostruoso Tifeo, infatti, il sovrano del cielo Zeus si riconcilia con le antiche divinità che riconoscono il suo ruolo, come Prometeo, che inizialmente ruba il fuoco dall’Olimpo per donarlo agli uomini (ancora una volta, come nella mitologia ebraica, il progresso umano è il frutto di una disobbedienza al comando del dio supremo) ma poi si riappacifica con il padre di tutti gli dèi; possono essere citati anche altri esempi: da Temi a Stige, dai figli di Notte a Ecate (è interessante notare, tuttavia, che il ruolo della dea Ecate, cui Esiodo dedica un ruolo importante nella sua Teogonia venga in seguito ridimensionato sino ad essere, per così dire, assorbito dalla figura di Artemide).
Una tale concezione della vita si riflette in tutta l’opera di Esiodo, poeta nativo della Beozia e vissuto nell’VIII sec. a.C. (Teogonia, Le opere e i giorni), e giunge sino all’opera del tragediografo Eschilo, che nella sua Orestea mette in scena il redde rationem tra gli dèi della vecchia generazione, impersonati dalle Erinni, e quelli della nuova generazione (Apollo e Atena), chiamati a decidere sulla colpevolezza di Oreste, il quale ha ucciso la madre su consiglio dell’oracolo di Delfi.
Il matricidio costituisce un crimine punito dalle vecchie leggi basate sul vincolo tra consanguinei (di cui le Erinni costituiscono il portavoce), ma può essere perdonato ove si consideri che esso è stato commissionato da Apollo per vendicare l’omicidio che Clitennestra, madre di Oreste, ha commesso nei confronti del marito: secondo la nuova legge della polis l’assassinio del proprio coniuge, infatti, ha un valore pari a quello commesso nei confronti di un membro della stirpe in quanto il matrimonio costituisce un legame altrettanto solido di quello di sangue.
La «vittoria» dei nuovi dèi viene sancita con l’assoluzione di Oreste da parte dei giudici dell’Aeropago di Atene, anche se in effetti il verdetto è tutt’altro che scontato: i giurati si pronunciano per metà a favore dell’accusato e per metà decretano la sua colpevolezza; con il suo voto Atena dichiara l’innocenza di Oreste. Le Erinni tuttavia non sono umiliate perché il loro culto viene ammesso ad Atene con tutti gli onori.
La genialità del pensiero greco sta nell’aver elaborato, nella propria religione, questa idea del graduale passaggio dal caos all’ordine: in questo kósmos ogni essere ha il suo ruolo e la sua importanza, che contribuisce alla sintesi armonica del tutto; cercare di sottrarsi al proprio ufficio ovvero andare oltre la propria funzione costituisce per gli Elleni un peccato di superbia (hýbris) che turba l’ordine naturale creando disarmonia e che porta alla punizione divina: tale reazione non culmina tuttavia in un atto repressivo che opera nel mondo terreno o ultraterreno (come nelle religioni orientali), ma è una reazione strumentale alla ricostituzione di un nuovo equilibrio.
Bibliografia essenziale:
Esiodo, Teogonia
Eschilo, L'Orestea
Villar, Gli Indoeuropei e le origini dell'Europa. Il Mulino, Bologna 1997.