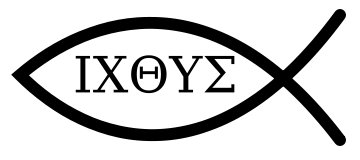Il secondo articolo sul Natale analizza, in modo necessariamente veloce e superficiale, il racconto della nascita di Gesù in relazione ad alcuni cliché mitici diffusi dalla Grecia all'India. Il discorso viene qui condotto unicamente nel campo della comparazione letteraria e mitologica. Ci limitamo a esporre delle osservazioni e delle ipotesi di lavoro: ai lettori trarre delle conclusioni.
Il racconto della nascita di Gesù è materia piuttosto delicata. Fa parte della nostra cultura e delle nostre più sentite tradizioni, e questo lo ammetteranno anche i laici, mentre i credenti gli conferiscono un valore di verità religiosa. Non è facile sfuggire alla tentazione dell'apologesi, o della polemica.
In questo articolo cercheremo in analizzare il racconto della nascita di Gesù con i metodi e gli strumenti della mitologia comparata. Che quel racconto sia esso stesso un mito mi sembra, più che una premessa, una necessaria definizione, e uso qui la parola «mito» in senso tecnico, a indicare una storia posta a fondazione di una tradizione, indipendentemente dalla sua validità storica.
Che alcuni temi presenti nella vicenda di Gesù mostrino affinità con altre biografie mitiche (Ḥurr, Diónysos, Hēraklês, Miθra...) è un'osservazione addirittura banale; e che il natale del Signore, tradizionalmente collocato il 25 dicembre, sia una festività rubata a ricorrenze solstiziali più antiche, è cosa ben risaputa. Gli studiosi, compresi i maggiori esegeti dei testi biblici e cristiani, sanno bene come il linguaggio mitico faccia uso di tópoi universali e come gli stessi simboli non facciano che rincorrersi e ritrovarsi in tutta la storia culturale e religiosa dell'umanità. Il concetto di copyright è moderno, e i miti non si inventano: si ereditano. I sapienti, i poeti, i mitografi, non pretendevano mai di essere «originali», ma si facevano interpreti di tradizioni più antiche, che adattavano a mutate realtà culturali e nuove ideologie. Il racconto evangelico non sfugge a queste regole.
Il mito della nascita di Gesù dipende dai vangeli di Matteo e Luca e da un certo numero di apocrifi, i cosiddetti «vangeli dell'infanzia». Non è qui il caso di fare un'analisi dettagliata delle fonti: al riguardo esiste una letteratura sterminata. Le due fonti canoniche sono differenti nel tono e (parzialmente) nel contenuto, e possono essere integrate, con le necessarie cautele. Ai fini della nostra analisi distinguiamo tre temi principali:
1. Il motivo del concepimento soprannaturale
La storia del concepimento soprannaturale di Gesù è riportato sia da Matteo che da Luca, con toni piuttosto diversi. La versione di Matteo assume il punto di vista di Giuseppe, la cui fidanzata Maria si scopre misteriosamente incinta. La reazione del mite falegname è piuttosto contenuta: vuole ripudiare la promessa sposa senza esporla a un pubblico scandalo. Ma ecco che un angelo, in sogno, gli rivela che il figlio di Maria, a cui egli metterà nome Gesù, è stato concepito ad opera dello Spirito Santo in modo da adempiere alle antiche profezie (Matteo [1, 18-25]). La versione di Luca, più fiabesca e aperta al meraviglioso, è invece tutta incentrata sulla giovane Maria, fanciulla di Nāṣǝraṯ, a cui compare l'arcangelo Gabriele, annunciandole la prossima maternità. L'arcangelo descrive il nascituro con vividi tratti regali e messianici: «sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di David, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine». (Luca [2, 26-38])
Prima di proseguire nella nostra analisi, bisogna sgomberare il campo da un falso problema. Il mitema di riferimento riguarda un concepimento soprannaturale. Il motivo della verginità di Maria è soltanto secondario, nonostante abbia avuto uno sviluppo teologico strabordante.
Nell'economia del racconto di Luca, la risposta sbigottita di Maria all'annuncio dell'angelo, «Come avverrà questo? Io non conosco uomo» [2, 34], è finalizzata a sottolineare la natura soprannaturale del concepimento di Gesù, futuro re e māšîªḥ di Israele. Analogamente, la notazione di Matteo, «[Giuseppe] prese con sé la sua sposa, ma non si accostò a essa fino alla nascita del figlio» [1, 24-25] serve soltanto a rassicurarci sul fatto che Gesù non era figlio di Giuseppe.
Nei testi evangelici il motivo della verginità riveste importanza accessoria, e non ha alcun intento morale: serve unicamente a sottolineare la natura soprannaturale del concepimento di Gesù. Nonostante ciò, già nei primi secoli del cristianesimo, la speculazione mariana ha dato enorme risalto al dato ginecologico, fino ad arrivare all'esasperazione del semper in virginitatis integritate della Madonna, prima, durante e dopo il parto.
Il mitema del concepimento soprannaturale, tradizionalmente legato alla nascita di un semidio, sovrano o salvatore, è talmente diffuso, dall'Irlanda all'India, che non vale quasi la pena di elencarne le infinite ricorrenze letterarie. Per i maggiori eroi greci, quali Perseús, Hēraklês, Thēseús, Akhilleús, è quasi la prassi essere figli di un dio e di una mortale. Si pensi anche alle nascite soprannaturali di Romulus, o di Servius Tullius nei miti monarchici romani, o di Conaire Mór e Cú Chulainn in quelli irlandesi. In India, il motivo del concepimento da parte di un dio diviene quasi una tecnica di fecondazione artificiale: nel Mahābhārata, le due mogli del principe Pāṇḍu, non potendo aver figli dal marito, utilizzano un mantra che permette loro di scegliere da quale dio farsi mettere incinte. Kuṃtī invoca Dharma, Vāyu e Indra, da cui ha rispettivamente i figli Yudhiṣṭhira, Bhīma e Arjuna (ma in precedenza aveva già avuto il primogenito Karṇa dal dio-sole Sūrya); Mādrī invoca i due Aśvinau e partorisce una coppia di gemelli: Nakula e Sahadeva. Questi cinque, più Karṇa, saranno gli eroi del poema.
In Italia, paese fieramente cattolico, il «dogma» del concepimento soprannaturale di Gesù viene presentato come evento unico e eccezionale, peraltro di natura storica, e non la semplice attestazione di un onnipresente leit-motiv letterario. Una visione «cristocentrica» che non aiuta a cogliere il significato simbolico di questo motivo mitico, significato ben conosciuto agli evangelisti, i quali lo hanno riletto e attualizzato alla luce della Buona Novella.
Ma proprio a causa della sua enorme diffusione, il mitema del concepimento soprannaturale poco ci aiuta a districare il complesso di motivi mitici legati al racconto evangelico. Bisognerà dunque sollevare lo sguardo e cercare degli schemi assai più precisi e dettagliati.
2. Il malvagio sovrano e il re neonato
In questo articolo cercheremo in analizzare il racconto della nascita di Gesù con i metodi e gli strumenti della mitologia comparata. Che quel racconto sia esso stesso un mito mi sembra, più che una premessa, una necessaria definizione, e uso qui la parola «mito» in senso tecnico, a indicare una storia posta a fondazione di una tradizione, indipendentemente dalla sua validità storica.
Che alcuni temi presenti nella vicenda di Gesù mostrino affinità con altre biografie mitiche (Ḥurr, Diónysos, Hēraklês, Miθra...) è un'osservazione addirittura banale; e che il natale del Signore, tradizionalmente collocato il 25 dicembre, sia una festività rubata a ricorrenze solstiziali più antiche, è cosa ben risaputa. Gli studiosi, compresi i maggiori esegeti dei testi biblici e cristiani, sanno bene come il linguaggio mitico faccia uso di tópoi universali e come gli stessi simboli non facciano che rincorrersi e ritrovarsi in tutta la storia culturale e religiosa dell'umanità. Il concetto di copyright è moderno, e i miti non si inventano: si ereditano. I sapienti, i poeti, i mitografi, non pretendevano mai di essere «originali», ma si facevano interpreti di tradizioni più antiche, che adattavano a mutate realtà culturali e nuove ideologie. Il racconto evangelico non sfugge a queste regole.
Il mito della nascita di Gesù dipende dai vangeli di Matteo e Luca e da un certo numero di apocrifi, i cosiddetti «vangeli dell'infanzia». Non è qui il caso di fare un'analisi dettagliata delle fonti: al riguardo esiste una letteratura sterminata. Le due fonti canoniche sono differenti nel tono e (parzialmente) nel contenuto, e possono essere integrate, con le necessarie cautele. Ai fini della nostra analisi distinguiamo tre temi principali:
- il concepimento soprannaturale di Gesù (Matteo, Luca);
- la nascita di Gesù tra i pastori (Luca);
- la rivalità tra Gesù e re Erode (Matteo).
1. Il motivo del concepimento soprannaturale
La storia del concepimento soprannaturale di Gesù è riportato sia da Matteo che da Luca, con toni piuttosto diversi. La versione di Matteo assume il punto di vista di Giuseppe, la cui fidanzata Maria si scopre misteriosamente incinta. La reazione del mite falegname è piuttosto contenuta: vuole ripudiare la promessa sposa senza esporla a un pubblico scandalo. Ma ecco che un angelo, in sogno, gli rivela che il figlio di Maria, a cui egli metterà nome Gesù, è stato concepito ad opera dello Spirito Santo in modo da adempiere alle antiche profezie (Matteo [1, 18-25]). La versione di Luca, più fiabesca e aperta al meraviglioso, è invece tutta incentrata sulla giovane Maria, fanciulla di Nāṣǝraṯ, a cui compare l'arcangelo Gabriele, annunciandole la prossima maternità. L'arcangelo descrive il nascituro con vividi tratti regali e messianici: «sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di David, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine». (Luca [2, 26-38])
 |
| Beato Angelico, "Annunciazione". |
Nell'economia del racconto di Luca, la risposta sbigottita di Maria all'annuncio dell'angelo, «Come avverrà questo? Io non conosco uomo» [2, 34], è finalizzata a sottolineare la natura soprannaturale del concepimento di Gesù, futuro re e māšîªḥ di Israele. Analogamente, la notazione di Matteo, «[Giuseppe] prese con sé la sua sposa, ma non si accostò a essa fino alla nascita del figlio» [1, 24-25] serve soltanto a rassicurarci sul fatto che Gesù non era figlio di Giuseppe.
Nei testi evangelici il motivo della verginità riveste importanza accessoria, e non ha alcun intento morale: serve unicamente a sottolineare la natura soprannaturale del concepimento di Gesù. Nonostante ciò, già nei primi secoli del cristianesimo, la speculazione mariana ha dato enorme risalto al dato ginecologico, fino ad arrivare all'esasperazione del semper in virginitatis integritate della Madonna, prima, durante e dopo il parto.
Il mitema del concepimento soprannaturale, tradizionalmente legato alla nascita di un semidio, sovrano o salvatore, è talmente diffuso, dall'Irlanda all'India, che non vale quasi la pena di elencarne le infinite ricorrenze letterarie. Per i maggiori eroi greci, quali Perseús, Hēraklês, Thēseús, Akhilleús, è quasi la prassi essere figli di un dio e di una mortale. Si pensi anche alle nascite soprannaturali di Romulus, o di Servius Tullius nei miti monarchici romani, o di Conaire Mór e Cú Chulainn in quelli irlandesi. In India, il motivo del concepimento da parte di un dio diviene quasi una tecnica di fecondazione artificiale: nel Mahābhārata, le due mogli del principe Pāṇḍu, non potendo aver figli dal marito, utilizzano un mantra che permette loro di scegliere da quale dio farsi mettere incinte. Kuṃtī invoca Dharma, Vāyu e Indra, da cui ha rispettivamente i figli Yudhiṣṭhira, Bhīma e Arjuna (ma in precedenza aveva già avuto il primogenito Karṇa dal dio-sole Sūrya); Mādrī invoca i due Aśvinau e partorisce una coppia di gemelli: Nakula e Sahadeva. Questi cinque, più Karṇa, saranno gli eroi del poema.
 |
| Kuṃtī invoca Sūrya |
In Italia, paese fieramente cattolico, il «dogma» del concepimento soprannaturale di Gesù viene presentato come evento unico e eccezionale, peraltro di natura storica, e non la semplice attestazione di un onnipresente leit-motiv letterario. Una visione «cristocentrica» che non aiuta a cogliere il significato simbolico di questo motivo mitico, significato ben conosciuto agli evangelisti, i quali lo hanno riletto e attualizzato alla luce della Buona Novella.
Ma proprio a causa della sua enorme diffusione, il mitema del concepimento soprannaturale poco ci aiuta a districare il complesso di motivi mitici legati al racconto evangelico. Bisognerà dunque sollevare lo sguardo e cercare degli schemi assai più precisi e dettagliati.
2. Il malvagio sovrano e il re neonato
C'è una sottoclasse piuttosto interessante di miti legati al concepimento soprannaturale che possiamo generalizzare nel modo seguente.
A un malvagio sovrano, geloso del proprio rango e dei propri privilegi, viene profetizzata la nascita di un bimbo destinato a detronizzarlo. Il re, che è spesso il padre o lo zio della ragazza destinata a dare alla luce il futuro rivale, prende tutte le precauzioni affinché ella non possa concepire un figlio. Nonostante ciò, la fanciulla si ritrova misteriosamente in dolce attesa e, presto, partorisce un bimbo. Infuriato, il sovrano ne ordina l'uccisione. A seconda delle versioni, il neonato viene portato via, scambiato con un sostituto, o abbandonato sulla corrente di un fiume. Sfugge comunque alla morte e, strappato alle grinfie del re, viene allevato lontano, in un ambiente bucolico, in mezzo ai pastori e alle loro greggi. Una volta cresciuto, torna indietro e rivendica i propri privilegi: elimina il sovrano e diviene re al suo posto.
Questo mitema è diffusissimo. Ne elenchiamo tre esempi, tratti rispettivamente dal mito greco, celtico e romano:
- Elleni. Ad Akrísios, re di Argo, viene profetizzato che perderà la vita e il trono a causa del figlio di sua figlia. Segrega dunque la ragazza, Danáē in una torre, con l'assoluta proibizione di incontrare uomini. Ma Zeús la visita trasformato in una pioggia d'oro e ben presto Danáē partorisce il figlio Perseús. Il re ordina che madre e figlio siano gettati in mare in una cassa di legno, augurandosi che finiscano per morire tra le onde. La cassa finisce però per spiaggiarsi su un'isola, e il bimbo può crescere tra i pescatori. Divenuto adulto, Perseús torna in Argo e uccide il nonno colpendolo casualmente con il disco nel corso di una gara. (Apollodoro: Bibliothḗkē [II: 4])
- Celti. Una fiaba irlandese narra di Balor, signore delle isole Ebridi, a cui viene profetizzata la morte per mano del figlio di sua figlia. Ordina allora che sua figlia Ethniu venga allevata da alcune nutrici sullo scoglio di Tór Inis, in modo che non venga nemmeno a sapere dell'esistenza di un sesso diverso dal proprio. Ma il giovane Cían delle Túatha Dé Danann, arrivato in Tór Inis, incontra Ethniu ed ha con lei un'intensa storia d'amore. In una versione della vicenda, la ragazza partorisce tre figli, e Balor ordina che vengano gettati in mare e annegati. Uno di loro, però, cade fuori dal sacco e Cían lo conduce in Ériu sulla barca di Manannán mac Lir. Divenuto adulto, Lúg ucciderà il nonno e diverrà re delle Túatha Dé Danann (John O'Donovan: Mac Kineely | William Larminie: West Irish Folk-Tales).
- Romani. Amulius, divenuto re di Alba Longa dopo aver spodestato il fratello Numitor, uccide i figli di questi, in modo che non possano contendergli il trono; dopodiché obbliga la figlia, Rea Silvia, al voto di castità delle sacerdotesse vestali. Ma nel corso di un temporale, in un bosco sacro, la ragazza viene presa con la forza dal dio Mars. Incinta, dà alla luce due gemelli. Amulius ordina che siano abbandonati in un cesto lungo il fiume Tevere. Così avviene: ma la cesta si arena in un luogo tra i colli Palatino e Capitolino, e i due bimbi vengono nutriti da una lupa. È un pastore, Faustolus, a trovarli e ad allevarli. Romulus e Remus crescono liberi tra pastori e briganti, finché scoperta la loro eredità, uccideranno Amulius e rimetteranno Numitor sul trono. Romulus fonderà Roma e ne sarà il primo re (Tito Livio: Ab Urbe condita libri [I, 3-6]).
Mentre la versione greca e quello celtica hanno una somiglianza talmente stretta che non si può escludere un passaggio diretto (la fiaba irlandese è stata raccolta nel Donegal intorno alla metà dell'Ottocento); la vicenda romana mostra un certo grado di rielaborazione e, oseremmo dire, di razionalizzazione. Qui non vi è alcuna profezia: re Amulius è abbastanza intelligente da rendersi conto che i discendenti del fratello cercheranno di ristabilire i diritti di Numitor, quindi fa del tutto per eliminarli. E Rea Silvia non viene segregata, ma soggetta alle regole di un sacerdozio. Sono cambiamenti poco significativi.
Si noti il dettaglio che i vari sovrani decidono di eliminare i bambini gettandoli in acqua. Solo nella versione celtica c'è un esplicito tentativo di annegamento; sia in quella greca che in quella romana l'ordine del re è curiosamente meno drastico: nell'una, madre e figlio saranno abbandonati in mare in una cassa di legno; nell'altra, i due gemelli vengono affidati alla corrente del fiume in una cesta di vimini. Una scelta tanto illogica non è giustificabile all'interno del racconto. Ma è significativo dal punto di vista letterario: le esigenze del racconto vogliono che i bambini siano destinati a salvarsi e a tornare per adempiere al loro destino. L'elemento liquido, lungi dall'essere strumento di morte, diviene strumento di separazione tra il malvagio sovrano e il re neonato, e dunque di salvezza per quest'ultimo.
 |
| Ernest Lee Major,"Danae" |
Il racconto della nascita di Gesù viene sviluppato separatamente in Luca e Matteo.
- Luca. Giuseppe e Maria si trovano a Bēṯlẹḥẹm, in Giudea, dove si sono recati in obbedienza al censimento ordinato dal governatore Quirino, quando per Maria si compiono i giorni del parto. Poiché non hanno trovato posto in albergo, ella depone il piccolo Gesù in una mangiatoia. La nascita del futuro māšîªḥ viene annunciata dagli angeli ai pastori che pernottano nei campi, i quali giungono per primi alla stalla per adorare il bambino (Luca [2, 1-20])
- Matteo. Gesù nasce a Bēṯlẹḥẹm. I magi, avendo visto una stella annunciare la nascita del re di Israele, arrivano a Gerusalemme per vedere il bambino. Re Erode, turbato e sospettoso, li chiama al suo cospetto e viene così a sapere della nascita del māšîªḥ. Invia allora i magi a Bēṯlẹḥẹm, ma chiede loro di tornare a riferirgli del bambino. I magi arrivano alla casa dove si trova Maria con il proprio figlioletto. Lo adorano e gli offrono in dono oro, incenso e mirra. Ma, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornano indietro da un'altra via. Il re, infuriato e deluso, ordina allora di uccidere tutti i bambini di Bēṯlẹḥẹm sotto i due anni. Ma Giuseppe, avvertito in sogno, ha già condotto Maria e suo figlio in Egitto, dove i tre rimarranno fino alla morte del re (Matteo [2, 1-20])
Per il resto, i due evangelisti focalizzano dettagli diversi della vicenda: Luca si concentra sulla nascita di Gesù tra i pastori, mentre Matteo racconta dell'arrivo dei magi e dei tentativi di re Erode di uccidere il bambino. I due racconti possono essere facilmente integrati l'uno con l'altro, trattandosi di due elementi di un medesimo schema mitico: quello del confronto/scontro tra il sovrano malvagio e il re neonato.
Ma prima di entrare nei dettagli, dobbiamo analizzare altre due storie, assai importanti, provenienti dalle due estremità del dominio indoeuropeo: l'una dalla Grecia, l'altra dall'India.
- Grecia. Krónos dai torti pensieri, l'ultimo dei titani, ha appena strappato a suo padre Ouranós il dominio supremo sull'universo. Un oracolo lo ha tuttavia avvertito che, com'egli ha rovesciato suo padre dal trono, sarà a sua volta spodestato da uno dei suoi discendenti. Così, quando la sua sorella-sposa Rhéa gli partorisce dei figli, il crudele titano li ingoia uno dopo l'altro, ed è questa la sorte di Hestía, Dēmḗtēr, Hḗra, Háıdēs e Poseidôn. Incinta per la sesta volta e decisa a salvare il figlio, Rhéa si reca di nascosto sull'isola di Creta e lì partorisce il piccolo Zeús. Subito la dea-terra Gê prende il neonato tra le braccia e lo nasconde in un antro scosceso. Il piccolo Zeús, nutrito con latte e miele, trascorre l'infanzia tra i pastori del monte Ida. Divenuto adulto, muove guerra a Krónos e prenderà il suo posto, regnando tra gli dèi. (Esiodo: Theogonía [453-490]; Apollodoro: Bibliothḗkē [I, 1]). In un'altra versione, i natali di Zeús sono collocati in Arcadia ed è la ninfa Nédē ad attraversare il mare per portare il neonato a Creta (Callimaco: Hymnia [I])
- India. A Kaṃsa di Mathurā, re degli Yādava, viene profetizzato che sarà detronizzato dal figlio di sua sorella Devakī. Il crudele re getta allora in prigione la donna, insieme a suo marito Vasudeva, e uccide sistematicamente i loro figli, man mano che vengono alla luce. Sette bambini vengono così eliminati. Quando Devakī partorisce per l'ottava volta, Vasudeva raccoglie il piccolo Kṛṣṇa ed esce magicamente dalla prigione. Ma il fiume Yamunā spalanca le acque dinanzi a Vasudeva, permettendogli di passare nel distretto di Vṛndāvana. Qui, in una casa vaiṣya, Yaśodā, moglie del pastore Nanda, ha appena partorito una figlia e Vasudeva sostituisce i due infanti. In seguito, scoperto l'inganno, re Kaṃsa ordina ai suoi uomini di uccidere tutti i neonati di Mathurā. Ma Kṛṣṇa, allevato da Nanda e Yaśodā, trascorre la sua infanzia nei boschi di Gokula, tra i ricchi pastori e le loro mogli. Il giovane cresce in compagnia di molte compiacenti pastorelle (gopī), finché, divenuto un uomo, torna a Mathurā, uccide re Kaṃsa e ne prende il posto.
Il racconto evangelico non pone una esplicita «fuga attraverso le acque», sebbene la famiglia di Giuseppe si sposti verso l'Egitto, con percorso inverso a quello compiuto, a suo tempo, da Mosè, che aveva aperto le acque del Mar Rosso per far passare il popolo ebraico, nell'esodo verso la Terra Promessa. La citazione non è casuale: anche Mosè si era salvato da una strage di bambini analoga a quella ordinata da Erode (e peraltro in una culla affidata alle acque del fiume). Anche il percorso di Giuseppe e Maria può dunque essere inserito, sebbene in maniera più implicita, nel solco di una tradizione relativa a una «fuga attraverso le acque».
Ultimo dettaglio, sia Zeús che Kṛṣṇa crescono in un luogo bucolico, in compagnia dei pastori e delle loro mandrie, come anche Romulus e Remus nel mito romano. Nel caso di Gesù il motivo compare soltanto in Luca, dove sono i pastori i primi ad accorrere ad adorare il bambino, particolare che appare del tutto scisso dal crudo racconto di Matteo della rivalità tra Gesù e Erode. In Luca, Gesù non si nasconde: i pastori fanno parte del paesaggio. La loro presenza in Luca, però, messa in relazione con il racconto di Matteo, rivela l'archetipo comune, il racconto del re bambino portato in salvo, in un ambiente semplice e pastorale, dalle mire del vecchio e malvagio sovrano.
I tre miti presentano anche altri elementi comuni, sebbene meno stringenti di quelli qui analizzati. Ai magi che visitano Gesù corrispondono i vecchi saggi che vanno a trovare il piccolo Kṛṣṇa. Notevole anche il motivo dei «doni funzionali» recati al divino fanciullo. I magi recano a Gesù oro, incenso e mirra, riconoscimento, rispettivamente, di regalità, sacerdozio e mortalità (ma le interpretazioni possono essere molteplici). Analogamente, la culla d'oro in cui Zeús viene messo a giacere è, ancora una volta, simbolo di regalità; le sue nutrici Thémis e Adrásteia rimandano a concetti di legge e giustizia; il latte e il miele con cui Zeús viene nutrito preludono all'ambrosía – cibo d'immortalità – che Zeús consumerà una volta preso il suo posto nell'Ólympos. La cornucopia, l'inesauribile corno dell'abbondanza della capra Amáltheia, assolve di nuovo a una funzione regale.
Stiamo dunque rilevando schemi piuttosto dettagli e complessi, comuni tanto alla Grecia quanto all'India, ancorché interpretati a volte in maniera divergente, i cui elementi sono regolarmente presenti anche nel racconto della nascita e dell'infanzia di Gesù. Stante l'ampia area di diffusione, che sembra rimandare a un archetipo indoeuropeo, possiamo ora chiederci come il racconto sia arrivato in Israele, e per qualche tramite sia stato adottato nei racconti evangelici.
 |
| Vasudeva e Kṛṣṇa |
Il mito della nascita di Kṛṣṇa non è affatto un caso isolato, nel mondo indoiranico. Si pensi al mito persiano di re Fereydūn, narrato da Ferdowsī nello Šāhnāmeh.
- Īrān. Il diabolico re Ẓaḥḥāk, che ha usurpato il trono dell'Īrān e imposto un regno di terrore che dura ormai da mille anni, sogna di essere abbattuto e sconfitto da un misterioso giovane armato da una mazza di ferro. I magi, interrogati, gli rivelano che il suo regno è destinato a finire per mano di un eroe, che però deve ancora nascere. Il bambino è Fereydūn, e Ẓaḥḥāk cerca di ucciderlo dal momento in cui viene alla luce. La madre fugge però sulle montagne e consegna il neonato a un pastore, affinché lo allevi e lo nutri con il latte delle migliori mucche. Divenuto grande, Fereydūn spodesterà Ẓaḥḥāk dal Trono d'Avorio, e diverrà re dell'Īrān.
Quando il re di Persia, Ciro il Grande (±560-530 a.C.), liberò il popolo ebraico dalla deportazione babilonese e lo annetté al suo sterminato impero, le tradizioni mazdee diedero ai teologi ebrei una gran quantità di materiale su cui riflettere. Il concetto lineare della storia, la credenza in una vita post mortem, il giudizio universale, l'idea di un salvatore escatologico (cfr. medio-persiano saošyant, avestico astvat-ǝrǝta), furono solo alcune delle concezioni persiane che fluirono in questo fervido crogiolo culturale e che gli ebrei elaborarono secondo gli stilemi della propria cultura. Il cristianesimo le ereditò a sua volta e le trasmise al canone religioso occidentale. Zaraθuštra può essere considerato a buon diritto uno dei fondatori culturali dell'occidente.
Lo stesso Ciro venne considerato dagli ebrei alla stregua di un liberatore, e non è escluso che fornì ai loro scribi e profeti un modello ideale per l'immagine di un sovrano universale. Ma sebbene Ciro sia un personaggio perfettamente storico, Erodoto racconta su di lui una curiosa vicenda...
- Erodoto. Astyágēs, re dei Medi, una volta ottenuto il potere sui persiani, sogna che dal grembo di sua figlia Mandánēs spunti una vite che, crescendo, finisce per ricoprire tutta l'Asia. I magi, chiamati a interpretare il sogno, gli rivelano che Astyágēs è destinato a essere spodestato dal figlio di sua figlia Mandánēs. Appena la donna dà alla luce il piccolo Kýros, Astyágēs chiama il fedele Hárpagos e gli consegna il neonato, già avvolto nei panni funebri, ordinandogli di ucciderlo. Ma Hárpagos ne incarica a sua volta un pastore, a nome Mithradátēs. Costui, invece di obbedire, decide di allevare il bambino, consegnando a Hárpagos il corpo del proprio figlioletto, nato morto. Kýros cresce così tra i pastori della Media; divenuto grande, fomenta una ribellione, si mette a capo dei persiani, muove guerra ai medi e li sbaraglia. Kýros diviene re dell'impero persiano e Astyágēs viene preso prigioniero (Historíai [I: 107-130])
Quello della nascita di Gesù a Bēṯlẹḥẹm è solo un dettaglio tra tanti: i vangeli sono intessuti di citazioni dai testi profetici; la biografia di Gesù è letteralmente ricostruita intorno ai segni indicati dai profeti cinque secoli prima.
In quest'ottica, non sembra affatto fuori luogo che si sia voluto associare a Gesù anche il tema del «malvagio sovrano e del re bambino», già presente nel mito del liberatore Ciro ed evidentemente avvertito come obbligatorio nella tradizionale biografia del re/salvatore. Matteo si premura di far discendere Gesù da re David (Matteo [1, 1-16]), creando le premesse per un conflitto di legittimità con lo stesso Erode, sovrano di origine edomita, privo di sangue reale, e insediato sul trono di Giudea grazie al sostegno di Roma. La situazione, così come l'evangelista ce l'ha scodellata, è perfetta perché vi si appoggi il motivo letterario, assai ben conosciuto, del «malvagio sovrano e del re bambino».
Conclusione
Terminiamo questa analisi, più letteraria che mitologica, sul racconto natalizio, con una domanda semplice e inevitabile: ma allora, tutto ciò che è narrato nei vangeli non è altro che la rielaborazione, in chiave cristologica, di antichi motivi letterari indoeuropei, ereditati dalla Persia, dalla Grecia?
Nel suo libro L'infanzia di Gesù, Benedetto XVI confronta il tema della nascita soprannaturale di Gesù con quella degli eroi greci e con la teologia regale reclamata dai faraoni egiziani; la sua conclusione è che si tratta di motivi completamente diversi, che non hanno nulla in comune.
Non ci aspettavamo certo una conclusione diversa, da parte del Santo Padre. Il suo libro sviscera molti affascinanti dettagli sui testi evangelici relativi alla nascita e all'infanzia di Gesù, sebbene dal punto di vista interno di chi i miti cristiani li vive come verità di fede.
Ma è anche una questione di metodo, oltre che di obiettività. Se confrontiamo tra loro i singoli mitemi (ad es. la «nascita soprannaturale»), otteniamo soltanto di evidenziare le differenze nel modo in cui tali mitemi sono stati applicati a storie tanto distanti – in termini geografici, culturali, ideologici – quali i miti greci/iranici e i racconti evangelici.
Se mettiamo però a confronto degli schemi dettagliati, ecco che le differenze si rivelano per ciò che sono: elaborazioni secondarie, locali, dovute al retroterra culturale e all'ideologia che sorregge i racconti. Ciò che si evidenzia è piuttosto l'incessante ripetizione di un medesimo motivo letterario, continuamente rielaborato e variato.
Conclusione
Terminiamo questa analisi, più letteraria che mitologica, sul racconto natalizio, con una domanda semplice e inevitabile: ma allora, tutto ciò che è narrato nei vangeli non è altro che la rielaborazione, in chiave cristologica, di antichi motivi letterari indoeuropei, ereditati dalla Persia, dalla Grecia?
Nel suo libro L'infanzia di Gesù, Benedetto XVI confronta il tema della nascita soprannaturale di Gesù con quella degli eroi greci e con la teologia regale reclamata dai faraoni egiziani; la sua conclusione è che si tratta di motivi completamente diversi, che non hanno nulla in comune.
Non ci aspettavamo certo una conclusione diversa, da parte del Santo Padre. Il suo libro sviscera molti affascinanti dettagli sui testi evangelici relativi alla nascita e all'infanzia di Gesù, sebbene dal punto di vista interno di chi i miti cristiani li vive come verità di fede.
Ma è anche una questione di metodo, oltre che di obiettività. Se confrontiamo tra loro i singoli mitemi (ad es. la «nascita soprannaturale»), otteniamo soltanto di evidenziare le differenze nel modo in cui tali mitemi sono stati applicati a storie tanto distanti – in termini geografici, culturali, ideologici – quali i miti greci/iranici e i racconti evangelici.
Se mettiamo però a confronto degli schemi dettagliati, ecco che le differenze si rivelano per ciò che sono: elaborazioni secondarie, locali, dovute al retroterra culturale e all'ideologia che sorregge i racconti. Ciò che si evidenzia è piuttosto l'incessante ripetizione di un medesimo motivo letterario, continuamente rielaborato e variato.
La storia della nascita di Gesù, dunque, non è vera?
La mia risposta è che certe «verità» possono essere espresse meglio dal mito, che non dalla storia.